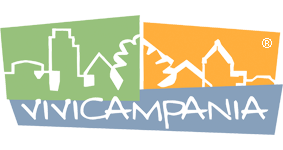La vita quotidiana a Casagiove in alcuni episodi di violenza carnale nell’Ottocento
Cesare Lombroso
Premessa
La vita quotidiana a Casagiove, come si è già visto in altre occasioni, non è stata scandita soltanto da eventi gioiosi, ma, purtroppo, a farla da padrone c’erano pure eventi del tutto tristi che, in qualche modo, compromettevano la tranquillità degli individui. Oltre alle semplici “scaramucce”, spesso capitava che uomini e donne si macchiassero di crimini efferati, sia fisici e sia psicologici che, concretamente, minavano l’esistenza delle vittime. Si tratta, come si potrà leggere, di violenze legate, purtroppo, anche alla società odierna, una società che in linea di massima è ormai lontana da determinati valori umani. Per i più sensibili, nelle due vicende prese in esame è riscontrabile un linguaggio alquanto “piccante”, citato nei documenti e che volutamente non si è voluto omettere, proprio per far comprendere come in realtà, l’essere umano faccia prevalere il più delle volte gli istinti “animaleschi”, pur essendo un “animale dotato di ragione”.
I. Ciliegie in cambio di violenza sessuale
Agli inizi dell’estate del 1854, un tal Simone Menniti “fu Saverio di Reggio” (si tratta di Reggio Calabria), dimorante in Casanova e che “prestava i suoi servigi” in quel comune “in qualità di parrella”, il 21 giugno di quell’anno, verso “l’ora meridionale” (mezzogiorno) invitò un ragazzo “di circa anni dieci” di nome Luigi Mincione, di seguirlo per andare a gustare insieme delle deliziose ciliegie. Il giovane si avviò col Menniti il quale lo condusse “fuori di questo abitato nella vicina cupa”. Una volta consumate le ciliegie, allora, il Menniti afferratolo lo gettò a terra e “sbottonatogli il calzone gli pose il membro virile nell’ano, e così lo stuprò”. Provvidenzialmente, però, nel corso dell’atto sessuale, si trovò a passare un soldato “guastatore dei granatieri della guardia Reale stanzionato in quel Comune”, il quale procedette tempestivamente all’arresto di entrambi, traducendoli poi in carcere per ordine dell’Intendente di Terra di Lavoro (Prefetto). Una volta raccolte le deposizioni dei due, risultò infatti che il giovanissimo Mincione era stato effettivamente stuprato ed infatti, immediato fu il suo rilascio. Interrogato l’imputato Menniti sulla colpa assegnatagli, invece, “costui è(ra) stato negativo” nelle risposte. Sul fatto, venne redatta anche una relazione, certamente, più dettagliata dei fatti. Quel 21 giugno 1854, il soldato del reggimento di stanza a Casanova, testimone oculare del fattaccio, mentre si trovava in una masseria nei tenimenti di Casanova, anche lui “a mangiare delle ciliegie”, ad un tratto udì “delle grida che partivano da un vicino territorio”. Il militare, quindi, “supponendo qualche cosa di sinistro” accorse trovandosi davanti una scena a dir poco agghiacciante: “trovò un ragazzo di circa anni sette in otto bocconi, ed un altro giovanotto, ch’egli precedentemente conosceva per i servigi che prestava nel quartiere armato, Simone Menniti di Reggio, il quale teneva l’asta virile al di fuori, ed il detto ragazzo piangendo gli disse che quel giovanotto a forza lo aveva afferrato e stuprato, promettendogli un grano (soldi)”. Il soldato, allora, dopo i severi rimproveri rivolti ad entrambi, li condusse innanzi al commissario di polizia a Caserta, quindi, gli arrestati furono “spediti” nelle prigioni di Santa Maria, “ed abbandonati al potere giudiziario”. Nel corso dell’interrogatorio, Luigi Mincione disse che il Menniti dopo avergli fatto mangiare le ciliegie in una casa fuori dall’abitato di Casanova, “ivi per forza lo stuprò”. Ma il fatto, per così dire, ancor più sconcertante della vicenda risultò essere la vista sul corpo del ragazzino Mincione di punti di sutura da cui appariva in maniera evidente che “era stato stuprato da più tempo” e pur non essendoci la presenza di arrossamenti ed infiammazioni, c’era tuttavia il sospetto “di un contagio sifilitico nell’ano”, con il conseguente pericolo di vita. Ad avvalorare la testimonianza resa nota dal soldato fu anche un tal Francesco Gallo “il quale ebbe manifestazioni non solo dal soldato suddetto”, ma anche dal ragazzo violentato “tanto e vero che piangeva ad accusare dolore nell’ano”.
Fonte: Archivio di Stato di Caserta, Corte Criminale, II camera – I volume, fascio 24 – procedimento 562 – fascicolo 1
II. Una spinta causa di aborto
Verso la fine del mese di aprile 1859, diversi individui, tra cui: Michele Papa “fu Vincenzo, di anni 48, muratore di Casanova”, Pasquale Sicampi “fu Salvatore, di anni 26, di Caserta, domiciliato in Casanova, falegname”, Giuseppe Fortuna “fu Antonio, di anni 48, di Caserta, domiciliato in Casanova, falegname”, Giuseppe Masciano “fu Antonio, di anni 32, di S. Nicola rialto, in provincia di Catanzaro, soldato del Reggimento 3° Cacciatori, stanziato a Casanova”, furono chiamati a testimoniare su di una rissa che era avvenuta a Casanova. Il primo testimone, Michele Papa, affermò che il 29 aprile “verso le ore 20”, “udì un subbuglio in mezzo la vicinissima strada” e poiché, a suo dire era “alquanto malato, stava in sua casa”, ritenne opportuno non uscire senza che, quindi, “potè vedere i particolari”. Soltanto successivamente venne a sapere “dal pubblico detto” che alcune persone, in particolare: Maria Brescia, Grazia Russo, Sizia Russo, Antonia Russo, Orazio Russo, Angelamaria Russo e Maria Santoro, tutte di Casanova, insieme “con molti altri” se le stavano dando di santa ragione attraverso le percosse attuate “con mani, zoccoli, pietre, ed altro”. La stessa analoga testimonianza venne poi espressa dai menzionati testimoni. Il fatto, certamente più doloroso della vicenda, non furono le “botte” in se per se, bensì la violenza fisica che purtroppo portò ad un aborto. Vittima di tale violenza fu Maria Santoro, moglie di Giuseppe Russo di Casanova che, appunto in quello stesso 29 aprile 1859, “accorsa per sovrapporsi in una rissa” provocata dal figlio Antonio Russo e da Antonio Centore, venne aggredita dalla moglie di quest’ultimo e dalle cognate Luisa, Anna, Maria Brescia, le quali “dandole una spinta, la fecero cadere, per il che, ed anche per lo spavento, in quel riscontro concepito, disse di essersi abortita di tre mesi, per aver cacciati dall’esterno dé pezzi informi di sangue aggrumito che aveva buttati via, senza saper distinguere se era o no l’embrione”. Al riguardo, poi, dei periti osservarono la Santoro “nelle parti genitali, ed avendo trovata la bocca dell’utero alquanto dilatata, gocciolante sangue”, giudicarono che la malcapitata “erasi abortita, e trovavasi perciò nel pericolo di vita” e pareva che si fosse creato “un forte infiammo che potevasi sviluppare nell’utero, dando luogo ad una uretrite, e sue conseguenze”. Sottoposta ad operazione “fu ravvisato svanito il temuto pericolo di vita” per la signora Maria Santoro. Alcune vicine di casa, nonché amiche della sventurata Maria: Margherita e Carolina Cutillo, Caterina Vozza e donna Marianna Verde affermarono, come pure la “pubblica voce”, che la Santoro “erasi abortita per effetto della rissa funesta” ed inoltre, le stesse amiche giudicavano Maria Santoro come “una donna dabbene, ed incapace a dire una cosa non vera”. Ulteriori testimoni entrarono in gioco aggiungendo “nuove specifiche sul caso”: si trattava di Carmina Bernardo, Francesco Sciampo, Bruno Ferrara, Sebastiano Nasta, i quali testimoniarono che Maria Santoro ricevette la spinta dalle Brescia, Anna, Maria e Luisa “e cadde a terra”. Un ulteriore testimone, Vincenzo di Pietro, sapeva con certezza che la Santoro “era gravida, perché abita(va) poco distante dalla casa della medesima”. La testimone Carmina Bernardo, testimoniando, disse che si era recata a visitare la malcapitata Maria Santoro, la quale, mostrandole “dé pezzi di sangue aggrumito ed informe disse che si era abortita”. La levatrice Raffaella Luongo visitò la Santoro, alla quale prescrisse “dello sciroppo”. Maria Brescia, con molta probabilità, la capobanda della violenza attuata, a suo dire, non solo si ridusse a spingerla facendola cadere, ma addirittura, non contenta e con l’aiuto di altri “la percossero con pugni, e le strapparono i capelli”. Pertanto, i chirurghi le operarono, fra l’altro, “una contusione nell’articolazione scapola – omerale giudicata pericolosa di storpio per gli accidenti”, pericolo che però, risultò svanito “colla 2° ispezione” dei periti.
Fonte: Archivio di Stato di Caserta, Corte Criminale, II camera – I volume, fascio 92 – procedimento 1653 – fascicolo 2